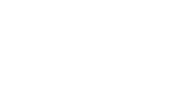stdClass Object
(
[id] => 14650
[title] => Mai offendere i poveri
[alias] => mai-offendere-i-poveri
[introtext] => Editoriali - Un dibattito incompetente
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire del 09/10/2018
[fulltext] =>
 Il primo e radicale problema di chi scrive, legifera e si occupa di povertà è l’incompetenza, perché non essendo in genere poveri non possediamo quella conoscenza specifica che ha soltanto chi è dentro una condizione di povertà. I discorsi e le azioni sulle povertà sono spesso inefficaci, se non dannosi, perché la mancanza di competenza li rende astratti. Non è certamente un caso che due tra i maggiori studiosi della povertà, Muhammad Yunus (premio Nobel per la pace) e Amartya Sen (premio Nobel per l’economia) sono originari rispettivamente del Bangladesh e dell’India, ed entrambi vengono da esperienze di contatto con le povertà vere e si sono sporcati le mani per contribuire a far nascere istituzioni e progetti per alleviare le povertà (la Grameen Bank e l’Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite). Per capire e operare nelle povertà il buon senso non basta e spesso produce molti danni. Dobbiamo invece lavorare molto, facendo di tutto per acquisire, con lo studio e la frequentazione delle persone che si vorrebbero aiutare, le competenze che non si hanno, ma che si devono avere.
Il primo e radicale problema di chi scrive, legifera e si occupa di povertà è l’incompetenza, perché non essendo in genere poveri non possediamo quella conoscenza specifica che ha soltanto chi è dentro una condizione di povertà. I discorsi e le azioni sulle povertà sono spesso inefficaci, se non dannosi, perché la mancanza di competenza li rende astratti. Non è certamente un caso che due tra i maggiori studiosi della povertà, Muhammad Yunus (premio Nobel per la pace) e Amartya Sen (premio Nobel per l’economia) sono originari rispettivamente del Bangladesh e dell’India, ed entrambi vengono da esperienze di contatto con le povertà vere e si sono sporcati le mani per contribuire a far nascere istituzioni e progetti per alleviare le povertà (la Grameen Bank e l’Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite). Per capire e operare nelle povertà il buon senso non basta e spesso produce molti danni. Dobbiamo invece lavorare molto, facendo di tutto per acquisire, con lo studio e la frequentazione delle persone che si vorrebbero aiutare, le competenze che non si hanno, ma che si devono avere.
La prima cosa che si inizia a capire quando si lasciano la scrivania e i set televisivi e si entra nella concretezza delle povertà, è l’inadeguatezza di una delle idee più radicate della sociologia del XX secolo, la cosiddetta "piramide di Maslow", che è troppo astratta per essere vera. Pensare, infatti, che le persone abbiano bisogni ordinati da una gerarchia piramidale, dove alla base ci sono i bisogni fisiologici (fame, sete, caldo e freddo…) e solo una volta soddisfatti questi possiamo permetterci il lusso di passare ai bisogni di ordine superiore (sicurezza e protezione), poi a quelli di appartenenza quindi ai bisogni di stima. E, infine, una volta saziati, riscaldati e stimati possiamo finalmente dedicarci al lusso dei bisogni di auto-realizzazione, che occupano il vertice della piramide. Come se le persone non morissero anche per mancanza di stima e di senso, o se l’attesa di una nipote che viene a visitarci ogni sera in ospedale ci nutrisse meno della minestrina. Questa antica teoria (del 1954) ha subito molte critiche, sviluppi, rettifiche, ma l’idea che ci siano bisogni primari ed essenziali legati al corpo, al coprirsi, al tetto, e solo dopo tutti gli altri più "alti", è ancora molto radicata nelle politiche pubbliche e nella cultura media della popolazione. E così la ritroviamo, implicita, anche nel dibattito sul reddito di cittadinanza di questi giorni in Italia (e non solo).
Quando ero bambino il reddito di mio padre (commerciante ambulante di polli e galline) è stato per molti anni minore degli equivalenti 780 euro di cui si parla oggi, e nessuno sapeva se ogni mese sarebbero arrivati a casa, dove ad attenderli c’era mia mamma e noi quattro figli. Ma nei compleanni e per la Befana i nostri regali dovevano essere belli come quelli dei nostri compagni di scuola più ricchi. Mio padre rinunciava anche ad alcuni beni primari, ma per quei giocattoli non faceva economia, perché non voleva che ci vergognassimo a scuola. In gioco c’erano la dignità sua e nostra. I miei nonni contadini e le loro sette figlie non erano certo benestanti, ma nelle feste importanti bisognava alzarsi da tavola lasciando vino e cibo avanzati. Quei pranzi eccessivi non erano meno essenziali delle patate e del pane di ogni giorno, perché erano momenti decisivi dove si ricreavano e accudivano quei legami sociali che stringevano tra di loro i membri della comunità, e impedivano che precipitassero tutti nei giorni difficili, quando alla mancanza dei beni primari supplivano questi altri beni altrettanto primari. Durante un periodo di studio all’estero, non avevo abbastanza soldi per permettermi un quotidiano (italiano) e il treno. Mi procurai da un amico una bicicletta, risparmiavo il costo del biglietto del treno e quei due franchi mi consentirono di leggere articoli che sono la radice di quelli che ho scritto molti anni dopo, e di quello che sto scrivendo ora.
La teoria della povertà di Amartya Sen si basa su un assioma fondamentale, una sorta di pietra angolare del suo edificio scientifico: la povertà è l’impossibilità che ha una persona di poter svolgere la vita che amerebbe vivere. La povertà è dunque una carestia di libertà effettiva, perché la mancanza di quelle che lui chiama capabilities (capacità di fare e di essere) diventa un ostacolo spesso insuperabile per fare la vita che vorremmo fare.
E una delle capacità fondamentali consiste, per Sen, nel poter uscire in pubblico senza vergognarsi (di sé e dei giocattoli dei propri bambini). Una delle idee economico-sociali più rivoluzionarie e umanistiche dell’ultimo secolo.
Il primo messaggio, serio e preoccupante, di questa visione competente della povertà riguarda la difficoltà di aumentare le libertà con il denaro. Alcuni, in genere la maggior parte, di questi ostacoli sono infatti conseguenza della mancanza non di reddito, ma di capabilities, che sono una sorta di bene capitale (stock), una assenza che si è creata negli anni, spesso già dall’infanzia. È l’assenza di capitali che genera anche la mancanza di reddito, che è solo un effetto. Questi beni capitali sono istruzione, salute, famiglia, comunità, talenti lavorativi, reti sociali, che per essere "curati" richiederebbero interventi strutturali, in "conto capitale", e quindi molto tempo, volontà politica e un coinvolgimento serio della società civile. Se quindi le persone non useranno il reddito che giungerà dal Governo per rafforzare o creare alcuni di questi capitali, quei soldi non ridurranno la povertà, perché le persone resteranno povere con un po’ di consumi in più. E il primo bene capitale da cui una persona può ricominciare si chiama ancora con un antico, bellissimo, nome: lavoro.
Ma c’è anche un secondo messaggio. Se questi 780 euro (al massimo) non diventeranno anche una maggiore libertà di comprare libri, giornali, di fare festa, un viaggio, di comprare un giocattolo bello per un bambino, un braccialetto più carino per la fidanzata, una cena esagerata con gli amici più cari per dire che finalmente stiamo cambiando vita, e che abbiamo ricominciato a sperare..., quei redditi non ridurranno nessuna povertà, o ne ridurranno gli aspetti meno importanti.
Tutti sappiamo, o dovremmo sapere, che per la stessa natura "capitale" di molte forme di povertà, il rischio che i soldi del reddito di cittadinanza finiscano in luoghi sbagliati è molto alto; e per questa ragione dobbiamo fare di tutto per eliminare e ridurre alcuni di questi luoghi sbagliati (in primis l’azzardo, dove il governo ha ben iniziato e deve andare fino in fondo togliendo le slot machine dai bar e tabacchi, e riducendo drasticamente i gratta-e-vinci che ormai si trovano ovunque). Ma se è vero che la povertà è mancanza di libertà, allora non offendiamo la libertà con liste di "beni primari" scritte a tavolino, o con controllori che dovrebbero dirci se un libro o un giocattolo sono troppo costosi perché un "povero" se li possa permettere. Il primo "reddito" di cui i molti poveri del nostro Paese hanno bisogno è un segnale di fiducia e di dignità. Di sentirsi dire che sono poveri ma prima sono persone adulte, e possono decidere, anche loro, se è più primario un vestito o un regalo per chi amano.
[checked_out] => 0
[checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
[catid] => 888
[created] => 2018-10-09 08:22:51
[created_by] => 64
[created_by_alias] => Luigino Bruni
[state] => 1
[modified] => 2020-08-10 04:40:22
[modified_by] => 609
[modified_by_name] => Super User
[publish_up] => 2018-10-09 08:37:22
[publish_down] => 0000-00-00 00:00:00
[images] =>
[urls] =>
[attribs] => {"article_layout":"","show_title":"","link_titles":"","show_tags":"","show_intro":"","info_block_position":"","info_block_show_title":"","show_category":"","link_category":"","show_parent_category":"","link_parent_category":"","show_associations":"","show_author":"","link_author":"","show_create_date":"","show_modify_date":"","show_publish_date":"","show_item_navigation":"","show_icons":"","show_print_icon":"","show_email_icon":"","show_vote":"","show_hits":"","show_noauth":"","urls_position":"","alternative_readmore":"","article_page_title":"","show_publishing_options":"","show_article_options":"","show_urls_images_backend":"","show_urls_images_frontend":"","helix_ultimate_image":"images\/2018\/10\/26\/181009_Mai offendere i poveri_ant.jpg","helix_ultimate_article_format":"standard","helix_ultimate_audio":"","helix_ultimate_gallery":"","helix_ultimate_video":"","multicats":"[\"888\"]"}
[metadata] => {"robots":"","author":"","rights":"","xreference":""}
[metakey] =>
[metadesc] => Editoriali - Un dibattito incompetente. Luigino Bruni su Avvenire del 9 ottobre2018
[access] => 1
[hits] => 8052
[xreference] =>
[featured] => 0
[language] => it-IT
[on_img_default] =>
[readmore] => 7887
[ordering] => 168
[category_title] => IT - Editoriali Avvenire
[category_route] => economia-civile/it-editoriali-vari/it-varie-editoriali-avvenire
[category_access] => 1
[category_alias] => it-varie-editoriali-avvenire
[published] => 1
[parents_published] => 1
[lft] => 79
[author] => Luigino Bruni
[author_email] => ferrucci.anto@gmail.com
[parent_title] => IT - Editoriali vari
[parent_id] => 893
[parent_route] => economia-civile/it-editoriali-vari
[parent_alias] => it-editoriali-vari
[rating] => 0
[rating_count] => 0
[alternative_readmore] =>
[layout] =>
[params] => Joomla\Registry\Registry Object
(
[data:protected] => stdClass Object
(
[article_layout] => _:default
[show_title] => 1
[link_titles] => 1
[show_intro] => 1
[info_block_position] => 0
[info_block_show_title] => 1
[show_category] => 1
[link_category] => 1
[show_parent_category] => 1
[link_parent_category] => 1
[show_associations] => 0
[flags] => 1
[show_author] => 0
[link_author] => 0
[show_create_date] => 1
[show_modify_date] => 0
[show_publish_date] => 1
[show_item_navigation] => 1
[show_vote] => 0
[show_readmore] => 0
[show_readmore_title] => 0
[readmore_limit] => 100
[show_tags] => 1
[show_icons] => 1
[show_print_icon] => 1
[show_email_icon] => 1
[show_hits] => 0
[record_hits] => 1
[show_noauth] => 0
[urls_position] => 1
[captcha] =>
[show_publishing_options] => 1
[show_article_options] => 1
[save_history] => 1
[history_limit] => 10
[show_urls_images_frontend] => 0
[show_urls_images_backend] => 1
[targeta] => 0
[targetb] => 0
[targetc] => 0
[float_intro] => left
[float_fulltext] => left
[category_layout] => _:blog
[show_category_heading_title_text] => 0
[show_category_title] => 0
[show_description] => 0
[show_description_image] => 0
[maxLevel] => 0
[show_empty_categories] => 0
[show_no_articles] => 1
[show_subcat_desc] => 0
[show_cat_num_articles] => 0
[show_cat_tags] => 1
[show_base_description] => 1
[maxLevelcat] => -1
[show_empty_categories_cat] => 0
[show_subcat_desc_cat] => 0
[show_cat_num_articles_cat] => 0
[num_leading_articles] => 0
[num_intro_articles] => 14
[num_columns] => 2
[num_links] => 0
[multi_column_order] => 1
[show_subcategory_content] => -1
[show_pagination_limit] => 1
[filter_field] => hide
[show_headings] => 1
[list_show_date] => 0
[date_format] =>
[list_show_hits] => 1
[list_show_author] => 1
[list_show_votes] => 0
[list_show_ratings] => 0
[orderby_pri] => none
[orderby_sec] => rdate
[order_date] => published
[show_pagination] => 2
[show_pagination_results] => 1
[show_featured] => show
[show_feed_link] => 1
[feed_summary] => 0
[feed_show_readmore] => 0
[sef_advanced] => 1
[sef_ids] => 1
[custom_fields_enable] => 1
[show_page_heading] => 0
[layout_type] => blog
[menu_text] => 1
[menu_show] => 1
[secure] => 0
[helixultimatemenulayout] => {"width":600,"menualign":"right","megamenu":0,"showtitle":1,"faicon":"","customclass":"","dropdown":"right","badge":"","badge_position":"","badge_bg_color":"","badge_text_color":"","layout":[]}
[helixultimate_enable_page_title] => 1
[helixultimate_page_title_alt] => Economia Civile
[helixultimate_page_subtitle] => Editoriali Avvenire
[helixultimate_page_title_heading] => h2
[page_title] => Editoriali Avvenire
[page_description] =>
[page_rights] =>
[robots] =>
[access-view] => 1
)
[initialized:protected] => 1
[separator] => .
)
[displayDate] => 2018-10-09 08:22:51
[tags] => Joomla\CMS\Helper\TagsHelper Object
(
[tagsChanged:protected] =>
[replaceTags:protected] =>
[typeAlias] =>
[itemTags] => Array
(
[0] => stdClass Object
(
[tag_id] => 13
[id] => 13
[parent_id] => 1
[lft] => 23
[rgt] => 24
[level] => 1
[path] => editoriali-avvenire
[title] => Editoriali Avvenire
[alias] => editoriali-avvenire
[note] =>
[description] =>
[published] => 1
[checked_out] => 0
[checked_out_time] => 0000-00-00 00:00:00
[access] => 1
[params] => {"tag_layout":"","tag_link_class":"label label-info"}
[metadesc] =>
[metakey] =>
[metadata] => {"author":"","robots":""}
[created_user_id] => 609
[created_time] => 2020-07-17 04:14:05
[created_by_alias] =>
[modified_user_id] => 0
[modified_time] => 2020-07-17 04:14:05
[images] => {"image_intro":"","float_intro":"","image_intro_alt":"","image_intro_caption":"","image_fulltext":"","float_fulltext":"","image_fulltext_alt":"","image_fulltext_caption":""}
[urls] => {}
[hits] => 48052
[language] => *
[version] => 1
[publish_up] => 2020-07-17 04:14:05
[publish_down] => 2020-07-17 04:14:05
)
)
)
[slug] => 14650:mai-offendere-i-poveri
[parent_slug] => 893:it-editoriali-vari
[catslug] => 888:it-varie-editoriali-avvenire
[event] => stdClass Object
(
[afterDisplayTitle] =>
[beforeDisplayContent] =>
[afterDisplayContent] =>
)
[text] => Editoriali - Un dibattito incompetente
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire del 09/10/2018
[jcfields] => Array
(
)
[type] => intro
[oddeven] => item-odd
)






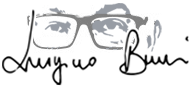
 Pubblichiamo uno stralcio del libro di Luigino Bruni
Pubblichiamo uno stralcio del libro di Luigino Bruni
 Economia è una parola greca che rimanda direttamente alla casa (oikos nomos, regole per gestire la casa), quindi alla famiglia. Eppure l’economia moderna, e ancor più quella contemporanea, si è pensata come un ambito retto da principi diversi, distinti e per molti versi opposti ai principi e ai valori che hanno sempre retto e continuano a reggere la famiglia. Un principio fondante la famiglia, forse il primo e quello sottostante gli altri, è quello di gratuità, che è quanto è di più distante dall’economia capitalistica, che conosce surrogati della gratuità (sconti, filantropia, saldi) che svolgono la funzione di immunizzare i mercati dalla gratuità vera.
Economia è una parola greca che rimanda direttamente alla casa (oikos nomos, regole per gestire la casa), quindi alla famiglia. Eppure l’economia moderna, e ancor più quella contemporanea, si è pensata come un ambito retto da principi diversi, distinti e per molti versi opposti ai principi e ai valori che hanno sempre retto e continuano a reggere la famiglia. Un principio fondante la famiglia, forse il primo e quello sottostante gli altri, è quello di gratuità, che è quanto è di più distante dall’economia capitalistica, che conosce surrogati della gratuità (sconti, filantropia, saldi) che svolgono la funzione di immunizzare i mercati dalla gratuità vera. Esiste una amicizia naturale tra l’Italia e il Bene comune, questa espressione che sentiamo risuonare, che sta nel cuore della Dottrina sociale della Chiesa,
Esiste una amicizia naturale tra l’Italia e il Bene comune, questa espressione che sentiamo risuonare, che sta nel cuore della Dottrina sociale della Chiesa,  Finché sulla terra ci sarà un idolo, avremo ancora bisogno di profeti. E dagli idoli la nostra società post-capitalistica appiattita sul feticismo del consumare – un culto con milioni di totem, oggi pure virtuali e personalizzati – è quasi divorata. L’umanesimo biblico che Luigino Bruni continua a esplorare in chiave sociale, economica e antropologica rappresenta anzitutto un antidoto all’idolatria. Ma non si svela pienamente trascurando i profeti: «Ci resta soprattutto precluso senza Isaia», afferma l’economista marchigiano, con il quale conversiamo in occasione dell’uscita del suo ultimo libro,
Finché sulla terra ci sarà un idolo, avremo ancora bisogno di profeti. E dagli idoli la nostra società post-capitalistica appiattita sul feticismo del consumare – un culto con milioni di totem, oggi pure virtuali e personalizzati – è quasi divorata. L’umanesimo biblico che Luigino Bruni continua a esplorare in chiave sociale, economica e antropologica rappresenta anzitutto un antidoto all’idolatria. Ma non si svela pienamente trascurando i profeti: «Ci resta soprattutto precluso senza Isaia», afferma l’economista marchigiano, con il quale conversiamo in occasione dell’uscita del suo ultimo libro,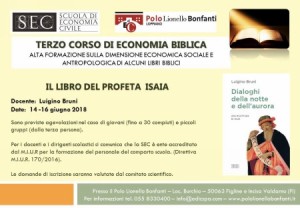 Lionello Bonfanti
Lionello Bonfanti «Le tematiche economiche e finanziarie, mai come oggi, attirano la nostra attenzione, a motivo del crescente influsso esercitato dai mercati sul benessere materiale di buona parte dell’umanità». Così inizia il documento
«Le tematiche economiche e finanziarie, mai come oggi, attirano la nostra attenzione, a motivo del crescente influsso esercitato dai mercati sul benessere materiale di buona parte dell’umanità». Così inizia il documento  Oggi è la festa dei lavoratori, di tutti lavoratori. È anche la festa del lavoro. Ma non è la festa di tutto il lavoro, perché non tutto il lavoro né tutti i lavori meritano di essere festeggiati. Il lavoro senza aggettivi qualificativi non parla abbastanza per dirci se merita o no la nostra festa.
Oggi è la festa dei lavoratori, di tutti lavoratori. È anche la festa del lavoro. Ma non è la festa di tutto il lavoro, perché non tutto il lavoro né tutti i lavori meritano di essere festeggiati. Il lavoro senza aggettivi qualificativi non parla abbastanza per dirci se merita o no la nostra festa.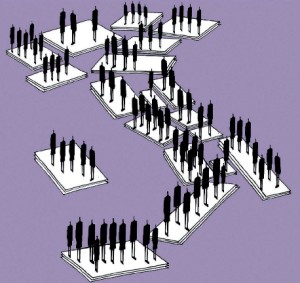 In queste settimane post-elettorali si sta riaccendendo il dibattito sulle diverse proposte di reddito di cittadinanza e sulle sue varianti. Il confronto è giustamente serio e appassionante, perché tocca cose molto importanti come la povertà, il lavoro, il non lavoro.
In queste settimane post-elettorali si sta riaccendendo il dibattito sulle diverse proposte di reddito di cittadinanza e sulle sue varianti. Il confronto è giustamente serio e appassionante, perché tocca cose molto importanti come la povertà, il lavoro, il non lavoro. Mercato, moneta, debito, profitto: nel grande racconto biblico sono già presenti la maggior parte delle categorie, anche economiche, che hanno fondato la nostra civiltà. A questo codice simbolico dell’Occidente, nel corso dei millenni, hanno attinto a piene mani la poesia, la letteratura e l’arte. Per non parlare della filosofia o della teoria politica. Persino la psicoanalisi, in anni recenti, si è avvalsa della potenza generativa degli archetipi vetero-testamentari allargando il bacino della saggezza greca, per dirla con Charles Moeller, grazie al paradosso cristiano. L’Economia no. Anzi: quello tra Bibbia ed Economia è un incontro per troppo tempo mancato al quale, proprio per questa ragione, Luigino Bruni ha scelto di dedicare, negli ultimissimi anni, una porzione rilevante della sua ricerca. Continua infatti anche nel 2018, al Polo Lionello Bonfanti, l’esperienza iniziata a giugno con la 'Settimana di Economia Biblica':
Mercato, moneta, debito, profitto: nel grande racconto biblico sono già presenti la maggior parte delle categorie, anche economiche, che hanno fondato la nostra civiltà. A questo codice simbolico dell’Occidente, nel corso dei millenni, hanno attinto a piene mani la poesia, la letteratura e l’arte. Per non parlare della filosofia o della teoria politica. Persino la psicoanalisi, in anni recenti, si è avvalsa della potenza generativa degli archetipi vetero-testamentari allargando il bacino della saggezza greca, per dirla con Charles Moeller, grazie al paradosso cristiano. L’Economia no. Anzi: quello tra Bibbia ed Economia è un incontro per troppo tempo mancato al quale, proprio per questa ragione, Luigino Bruni ha scelto di dedicare, negli ultimissimi anni, una porzione rilevante della sua ricerca. Continua infatti anche nel 2018, al Polo Lionello Bonfanti, l’esperienza iniziata a giugno con la 'Settimana di Economia Biblica':  Il mercato è uno, ma i mercati sono molti. Quando si parla e si discute seriamente di mercato e di Stato – poli di un dibattito che si vuol riaccendere anche usando lenti dal fuoco vecchio – dovremmo prima specificare di quale mercato e di quale Stato stiamo parlando. Perché è solo il Mercato con la "M" grande, creazione irreale e astratta delle ideologie, a essere uno solo. Ma se vogliamo capire cosa sta accadendo all’economia mondiale e in quella del nostro Paese, e magari cercare di migliorarla, dobbiamo uscire dal mondo incantato dei Mercati e degli Stati irreali.
Il mercato è uno, ma i mercati sono molti. Quando si parla e si discute seriamente di mercato e di Stato – poli di un dibattito che si vuol riaccendere anche usando lenti dal fuoco vecchio – dovremmo prima specificare di quale mercato e di quale Stato stiamo parlando. Perché è solo il Mercato con la "M" grande, creazione irreale e astratta delle ideologie, a essere uno solo. Ma se vogliamo capire cosa sta accadendo all’economia mondiale e in quella del nostro Paese, e magari cercare di migliorarla, dobbiamo uscire dal mondo incantato dei Mercati e degli Stati irreali. «Il capitalismo è una religione… In futuro ne avremo una visione più chiara». Scriveva nel 1922 il filosofo Walter Benjamin. Parole profetiche, perché mai come in questo nostro tempo il capitalismo della finanza e dei consumi “24ore7giorni” sta rivelando la sua natura religiosa o, meglio, idolatrica. Qualcosa di tanto rilevante quanto sottovalutato dai pensatori del nostro tempo. Non da John Milbank, anglicano, uno dei teologi contemporanei più profondi e influenti. Lo abbiamo incontrato in questo novembre 2017, alla Lumsa di Roma, in occasione del convegno internazionale “L’eredità di Martin Lutero nelle scienze economiche e sociali moderne”.
«Il capitalismo è una religione… In futuro ne avremo una visione più chiara». Scriveva nel 1922 il filosofo Walter Benjamin. Parole profetiche, perché mai come in questo nostro tempo il capitalismo della finanza e dei consumi “24ore7giorni” sta rivelando la sua natura religiosa o, meglio, idolatrica. Qualcosa di tanto rilevante quanto sottovalutato dai pensatori del nostro tempo. Non da John Milbank, anglicano, uno dei teologi contemporanei più profondi e influenti. Lo abbiamo incontrato in questo novembre 2017, alla Lumsa di Roma, in occasione del convegno internazionale “L’eredità di Martin Lutero nelle scienze economiche e sociali moderne”. Non è mai stato facile scrivere un’etica del denaro e dell’economia partendo dai vangeli. Riconoscere questa difficoltà, potrebbe in molti casi essere sufficiente per non iniziare un tale compito o fermarsi subito. Ma la tentazione di ricavare direttamente dal vangelo principi morali per l’economia della nostra società è molto forte, quasi invincibile. Qualche volta, anche chi legge questi libri sente un bisogno, anche questo invincibile, di scriverne una recensione, soprattutto se l’oggetto del libro sono i poveri e la povertà – che fanno spesso fatica a difendersi da soli dagli scrittori e dagli esperti. Ho fatto questa esperienza dopo la lettura di un piccolo libro di André Naud (1925-2002),
Non è mai stato facile scrivere un’etica del denaro e dell’economia partendo dai vangeli. Riconoscere questa difficoltà, potrebbe in molti casi essere sufficiente per non iniziare un tale compito o fermarsi subito. Ma la tentazione di ricavare direttamente dal vangelo principi morali per l’economia della nostra società è molto forte, quasi invincibile. Qualche volta, anche chi legge questi libri sente un bisogno, anche questo invincibile, di scriverne una recensione, soprattutto se l’oggetto del libro sono i poveri e la povertà – che fanno spesso fatica a difendersi da soli dagli scrittori e dagli esperti. Ho fatto questa esperienza dopo la lettura di un piccolo libro di André Naud (1925-2002), A chi interessa ciò che il mondo cattolico vive, pensa, propone in ambito sociale ed economico? Dal silenzio imbarazzante dei media cosiddetti laici sui lavori e sulle proposte della
A chi interessa ciò che il mondo cattolico vive, pensa, propone in ambito sociale ed economico? Dal silenzio imbarazzante dei media cosiddetti laici sui lavori e sulle proposte della 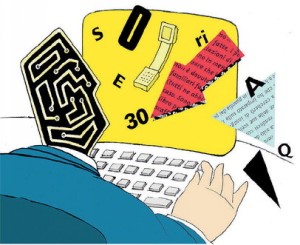 È
È