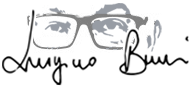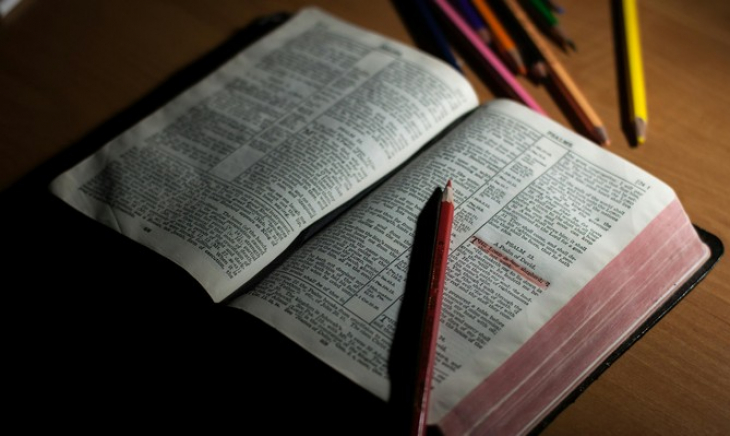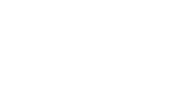Spiritualità - Una nuova collana editoriale propone il testo italiano senza note. Modalità che intende incoraggiare una lettura "immediata", in un abbraccio che lasci fuori il chiasso dei social
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 28/08/2025
Nel 1559, in pieno concilio di Trento, papa Paolo V fece redigere l’Indice dei libri proibiti (ribadito poi nel 1564 da Pio IV e nel 1596 da Clemente VIII, e giunto fino al Novecento), per cercare di controllare e frenare l’ingresso dei venti eretici della Riforma sotto le Alpi. Lutero aveva messo la Bibbia al centro della sua rivoluzione (sola Scriptura), e il mondo cattolico reagì mettendo la lettura diretta della Bibbia tra i sintomi di potenziali eretici. E così, tra i libri proibiti ai fedeli cattolici c’erano anche le traduzioni della Bibbia nelle lingue volgari, tra queste ovviamente anche l’italiano.
I primi due secoli della stampa videro molte edizioni della Bibbia in italiano. Se consideriamo non solo le edizioni integrali, ma anche quelle parziali, tra il 1471 e il 1562 furono stampate una settantina di Bibbie, quasi tutte a Venezia. In seguito, con la Controriforma apparvero quasi solo a Ginevra negli ambienti protestanti italiani. Abbiamo dovuto così aspettare l’età dell’Illuminismo, le spinte progressiste di Benedetto XIV, Antonio Ludovico Muratori o Antonio Genovesi perché, tra il 1769 e il 1781, si avesse una traduzione italiana della bibbia latina accettata dalla Chiesa cattolica, a cura dell’abate Antonio Martini. Una edizione rimasta di fatto l’unica ufficiale, sulla base della Vulgata latina, fino al Vaticano II e alla sua rivoluzione nella cultura biblica, che generò nuove e diverse versioni della Bibbia in italiano e nelle molte lingue moderne. Comunque, nei quattro secoli segnati dall’età della Controriforma (1565-1965), leggere la Bibbia in italiano, da soli o in gruppo, senza la presenza di un sacerdote, era esercizio scoraggiato. Nella costituzione Dominici gregis custodiae del Concilio di Trento del 24 marzo 1564 si legge: «Le traduzioni dei libri dell’Antico Testamento potranno essere concesse solo a uomini dotti e pii, a giudizio del vescovo, purché tali traduzioni vengano usate come spiegazione dell’edizione della Volgata per comprendere la Sacra Scrittura e non invece come un testo in sé autosufficiente». Insomma, il rapporto tra Chiesa cattolica e Sacra Scrittura non è stato lineare, e anche la teologia dalla Scolastica al Vaticano II non sentiva il bisogno di fondarsi direttamente nel testo biblico; in alcuni secoli Aristotele o lo pseudo-Dionigi erano considerati e citati forse più libro della Bibbia. Per non parlare poi dell’Antico Testamento, molto distante dalla formazione del popolo (anche se sempre molto presente nell’arte, che ad istinto lo amava molto). Marcione, che voleva escludere dal Canone cristiano tutto l’Antico Testamento, fu sconfitto dai Padri e considerato eretico, ma nella prassi il popolo cattolico ha continuato a pensare che “basta il Vangelo”, che l’Antico Testamento è molto complicato, distante e tutto sommato inutile o dannoso se non anticipa il Vangelo e Gesù. Una storia diversa è quella del monachesimo e della gran parte della vita consacrata, dove la Parola è pane quotidiano, è l’atmosfera e il grembo dove si svolge tutta la giornata e l’esistenza - ma, lo sappiamo, la cultura cattolica ha sviluppato due binari paralleli: quello per i monaci, monache e suore, e quello per i laici.
Poi è arrivato il Concilio Vaticano II con la sua svolta relativa anche alla frequentazione della Parola, raccomandata e rilanciata a tutti i livelli: «È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla sacra Scrittura» (Dei Verbum); ma secoli di tradizione poco o affatto biblica non si cambiano nel giro di una o due generazioni. C’è dunque ancora molto da fare per arrivare ad una cultura cattolica amica della Bibbia, di tutta la Bibbia, che è davvero urgente. Non supereremo l’impatto, per ora devastante, con la cultura moderna e scientifica senza una vera formazione biblica, quotidiana e seria, che superi l’approccio naif, improvvisato e spiritualista che spesso si trova in alcuni gruppi e movimenti, dove si legge e magari si vive il Vangelo, senza però che tutto ciò sia accompagnato da una cultura biblica, che è ben altra e seria cosa rispetto al semplice leggere e mettere in pratica il Vangelo. Una seria cultura biblica è anche la buona strada per far sì che i giovani, una volta diventati adulti, possono continuare l’esperienza cristiana, quando occorre cercare fondamenta più profonda delle emozioni.
Ecco perché non possiamo che accogliere con entusiasmo l’iniziativa della casa editrice La Vela, di Lucca, che ha lanciato una nuova e innovativa collana, I libri della Bibbia, a cura di Sergio Valzania. Piccoli libri, molto ben curati già a partire dalla scelta dell’immagine di copertina. La sfida della nuova impresa culturale la troviamo indicata nel retro di copertina dei singoli volumi: «Questa collana propone i libri della Bibbia nella traduzione curata dalla CEI, in un formato agile, senza note e commenti». Libri che quindi contengono soltanto il testo italiano del libro biblico, introdotto da una paginetta del curatore Sergio Valzania. Tutte le Bibbie, anche quella di Diodati (protestante) o di Martini, sono sempre state accompagnate da note a pie’ di pagina, anche se spesso si limitavano a riferimenti incrociati di altri passaggi biblici e poco più. Valzania e La Vela hanno invece stampato il testo senza note, non per favorire un approccio magico e ingenuo alla Bibbia, ma per alleggerire e quindi incoraggiare la prima lettura del nudo testo, sine glossa. La prima buona lettura della Bibbia è un corpo a corpo senza mediatori, come quello tra Giacobbe e l’angelo nel guado notturno dello Jabbock (capitolo 32 della Genesi). Un combattimento che è anche un abbraccio, che ci ferisce e ci benedice, perché dopo la prima lettura ne servirà una seconda, e lì le note e i commenti tecnici saranno essenziali.
Per ora sono stati pubblicati tre libri: Genesi, Cantico e Qoelet (l’Ecclesiaste). Una nuova bella avventura editoriale, rischiosa come tutte le innovazioni. E noi non possiamo che augurarle un buon cammino, tra credenti e anche non-credenti, perché la Bibbia è un bene comune globale per tutti, per ogni persona interessata ad esplorare il mistero e la bellezza del mondo. La Bibbia è molte cose, tutte importanti, ma è soprattutto un addestramento al senso e alla vocazione della parola, delle parole, di Dio e delle nostre. In un tempo abitato da chiacchiere, intelligenza artificiale e fake news, attraversare la Bibbia è un esercizio straordinario e necessario per apprendere la disciplina della parola. Un ultimo consiglio personale per questa prima lettura del testo biblico. Spegnete il cellulare, recatevi, sa soli o in compagnia, in un luogo aperto, silenzioso, possibilmente con alberi, uccelli, natura. E lì sarà possibile riudire, qui ed ora, il suono e il senso della parola: «In principio Dio creò il cielo e la terra».
Credits foto: Foto di John-Mark Smith su Pexels