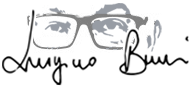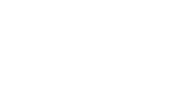Agorà - Pietro Del Soldà nel suo ultimo saggio mette in guardia dalla fusione e dell’ossessione identitaria, patologie che sono una minaccia per la democrazia
di Luigino Bruni
pubblicato su Avvenire il 23/10/2025
Pietro del Soldà, filosofo e noto e apprezzato giornalista di Radio 3, continua con Amore e libertà Per una filosofia del desiderio (Feltrinelli, pagine 176, euro 18,00) la sua riflessione sulla libertà, sull’amicizia e sull’amore, che sono tutte parole prima della vita, individuale e collettiva. Un libro scritto con una prosa brillante, colta, coinvolgente, a tratti poetica. É un libro sull’amore e sulla libertà, e sulla possibilità e necessità di declinarli insieme, di dire l’uno dicendo l’altro, e nel dirli reciprocamente capirne le sfide, i paradossi, le incompiutezze, e i tranelli.
Già nella Introduzione troviamo molte delle tesi del libro: “Non c’è felicità al di fuori dell’amore, dice Diotima nel Simposio, e non c’è neppure desiderio: se è privo di slancio erotico, infatti, non è vero desiderio, non mi scuote nel profondo, non mi fa sperimentare quello stato di privazione radicale che è invece l’essenza del desiderio e così non mi consente di sfiorare l’eudaimonia, la felicità che scaturisce dall’accordo con il daimon, la mia “parte divina”: se non amo e non sono amato, a questo accordo non ci arriverò mai”. Amore è quindi amare ed essere amati. Del Soldà sa bene che l’eudaimonia di Platone, di cui ci parla, non coincide con quella di Aristotele, dove la felicità è poco associata al daimon divino e molto alle virtù, soprattutto a quelle civili. Il discorso di Del Soldà è, infatti, un discorso sull’amore che parte dalla visione che ne ha Platone, e questo immenso filosofo resta l’asse principale costante con cui metterà in relazione i molti altri autori che ci farà incontrare (Plotino, Agostino, Hegel, Girard, Nietzsche, Simmel, Dumont, etc: un indice dei nomi sarebbe stato utile). Il punto delicato, che introduco subito, è se sia possibile e generativo articolare un discorso sull’amore declinandolo soltanto, o primariamente, come eros. Lo vedremo alla fine di questa nota.
Ma, aggiunge subito l’autore, “Amore, avverte Diotima, è anche un astuto ingannatore, doleros, un “orditore di tranelli””, anche perché figlio di poros, cioè espediente. Quindi per gestire o domare eros (Del Soldà ricorre spesso al mito platonico dell’auriga), con l’eros occorre parlare, non è solo passione irrazionale, non deve diventarlo: “Logos ed Eros, in fondo, non sono affatto due nemici, al contrario, la grande lezione della filosofia greca è che il loro legame è profondo, indistricabile: l’uno può rischiarare le zone d’ombra dell’altro”. Eros non dialoga solo con il Logos, parla continuamente anche con Tanatos, il terzo asse di ogni discorso sull’amore-eros, e forse sull’amore in generale.
E arriviamo subito alla tesi centrale - almeno una delle più importanti - del libro: “Saper vivere in fondo la propria natura erotica significa aprirsi all’ignoto e all’alterità: l’“amore libero”, eleutheros eros, di cui parla Socrate a Fedro e che dobbiamo inseguire contro ogni ostacolo, è il principale antidoto a quella “ossessione identitaria” che oggi rappresenta la principale minaccia per la democrazia”. Del Soldà sviluppa infatti il suo discorso sull’amore muovendosi tra sue due derive o patologie. La prima è quella della fusione, “che aspira a fondere gli amanti in una cosa sola” e che trova la sua prima manifestazione nel “celebre mito narrato da Aristofane nel Simposio”, cioè "ricomporre l’unità perduta di quell’essere primigenio che esisteva nei tempi di remoti”. La seconda malattia è quella “dell’identità personale che se ne sta nel suo recinto ad attendere il riconoscimento degli altri e viene anteposta a ogni relazione coinvolgente”. Qui si rinuncia alla natura nomadica dell’eros, perché la vita buona sta nel “lasciarci andare, nel ‘gettare via la vita’, anche in amore: abbiamo bisogno di cadere e non dobbiamo averne paura. O meglio, la paura ci accompagnerà sempre … E va bene così”. Senza finire, però, nel mito della fusione. Le pagine sulla critica di chi decide di smettere di vivere per paura di morire, di non tentare l’avventura brada di eros solo per paura di tanatos, sono le pagine più belle e dense del libro, e che rivelano un tratto di pensiero originale.
Per provare ad uscire da questa specie di scelta tragica, Del Soldà trova aiuto in Platone (Fedro), in Lucrezio, e nella politicizzazione dell’eros: “L’amore è, e sarà sempre, l’emersione del desiderio essenziale di quella strana creatura, l’essere umano… che continua a essere ciò che è sempre stato: zoon politikon, un “vivente politico” che parla, pensa, esprime le emozioni e organizza la sua vita in uno spazio comune, la polis”.
IImportanti e belle sono poi anche le pagine dedicate, sulla scia di Lacan (e di Recalcati), alla incompetenza dell’eros dovuto alla natura reciproca del desiderio, il suo essere desiderio di un desiderio desiderante: “Il mio desiderio non è desiderio di te e basta, come se tu fossi un oggetto inerte (una preda, appunto), ma è desiderio del tuo desiderio”. Il bisogno della desiderabilità rende la “reciprocità dell’amore, dunque, a un tempo piena e imperfetta, compiuta e irraggiungibile. Un altro enigma, insomma”. Da qui l’individuazione di un nodo centrale del mistero dell’amore-eros: “Se l’incontro tra gli amanti è perfetto e cristallino, senza ombre, se non s’insinua anche solo una crepa sottile a incrinare il processo di riconoscimento, allora è probabile che le cose andranno a finire male”. Nell’amore ci deve dunque essere “il desiderio di mancarsi, di non capirsi, o di capirsi solo in parte”.
La ricerca sull’eros come libertà porta Del Soldà ad esplorare soluzione ardite, come il superamento della coppia: “Non è detto che un eventuale superamento della coppia – almeno per come l’abbiamo conosciuta sin qui – sia per forza un male. Non è sicuro che porterebbe per forza al tramonto del sentimento amoroso”. Facciamo fatica a seguire l’autore in questo travalicamento della coppia nell’amore erotico. Per capire questa fatica (rispettosa), occorre aprire un discorso sulle forme dell’amore.
Il libro di Del Soldà parla primariamente dell’eros. Ma, il mondo greco e poi il cristianesimo e quindi l’umanesimo occidentale, ci parla di molti amori: l’amore una semantica plurale. Eros è la forma dell’amore al centro del discorso di Platone, e di altri greci. Aristotele nelle sue Etiche ci parlerà anche soprattutto della philia, di cui, tra l’altro, anche Del Soldà ha parlato a lungo nel suo precedente saggio Sulle ali degli amici (2022). La Philia non è l’eros, le somiglia, non è il suo opposto, ma è un’altra forma dell’amore. Il mondo greco conosceva poi l’amore per i fratelli, per le sorelle, o per i genitori. I vangeli e Paolo, poi, ci hanno parlato di una terza forma di amore, l’agape.
Il lessico greco cristiano era capace di distinguere il "ti voglio bene" detto alla donna amata dal "ti voglio bene" detto a un amico, e allo stesso tempo riconoscere che il secondo non era né inferiore né meno vero del primo. Il cristianesimo, poi, ha aggiunto una terza parola greca per dire un’altra tonalità dello stesso amore, già presente nella Bibbia ebraica e, soprattutto, già presente nella vita. Questa terza, stupenda, parola è agape, l’amore che sa amare chi non è desiderabile e il non-amico.
Sono dimensioni dell’amore che, spesso, si trovano insieme nei rapporti veri e importanti. Certamente nell’amicizia, dove la philia non è mai sola, perché è lei la prima ad avere bisogno di amici. È accompagnata dal desiderio-passione per l’amico ed è irrorata dall’agape che le consente di poter durare, di risorgere dai nostri fallimenti e dalle nostre fragilità. Un’amicizia che è solo philia non è abbastanza calda e forte per non lasciarci soli sulle nostre strade. Ma è la philia che lega l’eros e l’agape tra di loro, e li affratella – anche Gesù ha avuto bisogno del registro della philia per dirci il suo amore. In quelle pochissime amicizie che ci accompagnano per lunghi tratti di vita, a volte fino alla fine, la philia racchiude in sé anche i colori e i sapori dell’eros e dell’agape. Sono quegli amici che abbiamo perdonato e che ci hanno perdonato settanta volte sette, quelli che quando non tornavano sono stati attesi e desiderati come una sposa o un figlio. Quelli che abbiamo abbracciato, baciato come e diversamente da altri abbracci e da altri baci, quelli con i quali abbiamo mischiato molte volte le lacrime fino a fonderle nella stessa goccia salata. Ecco perché pochi dolori sono poi più grandi di quello per la morte di un amico – in quel giorno, un pezzo di cuore smette di battere, e non ricomincia più. Non c’è soltanto una lotta radicale tra eros e tanatos; ce n’è un’altra, simile e diversa, tra philia e tanatos, e ci sono amici che continuano a vivere, a resistere al dolore e alla malattia, solo perché attendono di rivederci nella nostra prossima visita a casa o all’hospice, quando quel philos che viene vale tutta la vita, tutta la philosophia della terra.
La philia e ancor più l’agape aprono l’amore della coppia, la portano a trascendersi e superarsi. Più difficile pensare ad un buon superamento della coppia se restiamo nel solo registro dell’eros. Certo l’amore è libertà, come recita il titolo del libro, ma l’amore non è soltanto libertà. L’amore umano è molte cose, va declinato con molte parole che qualificano, esaltano e limitano il campo di azione della libertà. Innanzitutto anche la libertà è parola plurale (libertà da, libertà di, libertà con, libertà per …), e alcune di queste preposizioni richiamano direttamente la parola gemella di una buona libertà civile e politica: responsabilità. Perché se l’incontro erotico è un incontro di individui totalmente disimpegnati e irresponsabili gli uni degli altri, quella libertà genera solo inganni e infelicità, alcune delineate anche da Del Soldà nella prima parte del saggio. Perché, come messo in luce nel capitolo 4, l’eros ha un nesso unico e inscindibile col corpo e con le tipiche responsabilità del corpo (il corpo non è solo bellezza e desiderio).
Per un amore responsabile non basta l’eros. Non basta alla famiglia, alle moglie, ai mariti, non basta ai bambini, non basta perché le ferite nostre e degli altri siano sostenibili e possibili.