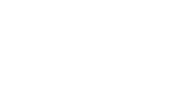Letture - "Per una nuova prosperità. Quattro vie per una crescita integrale." Mauro Magatti e Laura Gherardi, Feltrinelli, 2013.
di Luigino Bruni
pubblicato su Sussidiario.net il 12/03/2014
 Un certo capitalismo, quello che abbiamo conosciuto prima della globalizzazione, è morto per sempre, ma lo spirito del capitalismo è vivo; si è solo trasformato, e continua a soffiare forte sulla terra.
Un certo capitalismo, quello che abbiamo conosciuto prima della globalizzazione, è morto per sempre, ma lo spirito del capitalismo è vivo; si è solo trasformato, e continua a soffiare forte sulla terra.
La crisi finanziaria del 2007 è stata l’esplosione di un processo iniziato almeno a partire dagli anni ottanta del secolo XX, ma è un punto di non ritorno.
Se vogliamo, allora, capire che cosa sta accadendo al nostro mondo (e quindi al nostro capitalismo), dobbiamo prendere coscienza che siamo dentro una profonda trasformazione che ci porterà altrove, della quale si intravvedono già primi segnali – la ‘nuova ecologia politica’ e i nuovi indicatori di benessere; il convivialismo e nuovi stili di vita attorno ai beni comuni (dal quale viene esclusa la ‘decrescita’, verso la quale si intravvede nel libro una certa diffidenza); l'economia della contribuzione teorizzata da Bernard Stiegler; la generatività tipicamente italiana di cui è capofila lo stesso Magatti.
Questi segnali vanno interpretati non come eccezioni ad una regola (quella del capitalismo di ieri), ma come primizie di un nuovo raccolto, che potrà essere, per gli autori, anche più buono e “prospero” di quelli che abbiamo conosciuto. L’avvento di quello che chiamano ‘capitalismo a valore contestuale’.
È questa la tesi del libro di Magatti e Gherardi, un libro che va letto soprattutto per le grandi domande che pone, e poi per le prospettive che apre – e anche per domande che non pone direttamente, ma che ci suscita. Prendendo le mosse da un classico come Max Weber (“L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”) e dal più recente trattato dei sociologi francesi Luc Boltansky e Eve Chiapello (“Il nuovo spirito del capitalismo”), Magatti e Gherardi ci dicono che il moderno spirito del capitalismo è costituito soprattutto dalla sua capacità di riciclare le critiche che ha incontrato lungo la sua storia (recente), inglobarle e farle diventare principali fattori di cambiamento e di innovazioni. Così, le critiche “sociali” (socialiste, comuniste, operaie, ambientaliste …) e quelle “estetiche” (degli intellettuali, dei creativi, degli artisti), invece di provocare il crollo del capitalismo, sono state incorporate dando vita ad nuovo capitalismo. Così un capitalismo fondato su valori che erano visti, nel Novecento, in antitesi ad altri valori diversi e non riconducibili ad unum (libertà vs eguaglianza; efficienza vs equità; sviluppo vs ambiente; quantità vs qualità; standardizzazione vs creatività; consumo vs spiritualità; ecc.), negli ultimi decenni si è mostrato capace di riciclare e sciogliere molte di queste antitesi. Così nelle imprese, soprattutto in quelle grandi, assistiamo sempre più allo sviluppo di bilanci sociali, di social business, di attenzione al benessere lavorativo, alle pratiche di attenzione alle pari opportunità di genere, fino ai recenti concetti di ‘capitale simbolico” o “spirituale’ dell’azienda. Parallelamente all’inclusione e trasformazione delle critiche sociali, questo capitalismo ha internalizzato anche le critiche “estetiche”, dato vita ad una nuova stagione creativa mettendo al centro proprio la figura del “creativo” (nel web e non solo).
Gherardi e Magatti riprendono questa tesi di Boltansky-Chiapello, ma la estendono e sviluppano, anche perché l’analisi dei due sociologi francesi si era fermata al pre-rivoluzione finanziaria dell’economia (anni 90’) – e qui sta il punto, solo in parte sviluppato da Magatti e Gherardi –, quando il nostro capitalismo ha mutato pelle e forse natura.
Hic rodhus, hic salta. Se guardiamo bene questo processo di ‘internalizzazione’ delle critiche, questo non è molto diverso, nella sua logica, da quanto è accaduto con gli altri grandi imperi della storia (si pensi in particolare all’impero romano) che sono cresciuti e sono durati secoli proprio per aver incorporato i ‘nemici’ che premevano alle frontiere, e poi prendere da loro (dagli etruschi ai greci ai popoli germanici) la migliore cultura, tecnica, arte. Quindi, in altre parole, la capacità inclusiva e riciclante del capitalismo, il suo essere una sorta ‘mostro’ camaleontico che cambia forma in base all’ambiente e agli ostacoli che trova, non è altro che il suo essere molto più di una forma di produzione di ricchezza e di consumo della stessa, una natura globale, imperiale e inglobante del capitalismo già intuita dallo stesso Marx e dal marxismo. Gli imperi assicurano panem et circenses ad una parte dei popoli che ingloba, ma un’altra parte li fa schiavi, e un’altra la uccide nel processo di conquista.
Per questa ragione trovo rilevante e centrale l’enfasi posta dagli autori sulla diseguaglianza, indicata come una malattia che questo capitalismo non riesce né a inglobare né tantomeno a guarire. Infatti, mentre la prima economia di mercato e il primo capitalismo (XVIII-XX secoli) hanno veramente ridotto la diseguaglianza, e combattuto indirettamente le varie forme di feudalesimo, il capitalismo finanziario o “tecno nichilista” (Magatti) sta riportando la nostra economia ad una situazione molto simile a quella pre-moderna, perché sta riportando la centralità sulle rendite (e non sui flussi, tra i quali il lavoro e i profitti), che è la tipica nota di ogni società feudale. Come un altro francese, Thomas Piketty (economista), ha messo in luce nel suo ultimo grande (e grosso) volume “Le Capital au XXIe siècle”, la rendita sui capitali sta tornando ad essere la grande minaccia del nostro capitalismo, esattamente come prima del secolo XX. Quando, infatti, il tasso di rendimento del capitale supera significativamente e per lungo tempo il tasso di crescita, i patrimoni provenienti dal passato si ricapitalizzino più velocemente dell’aumento della produzione e dei redditi. In altre parole, le rendite mangiano i profitti e i salari – come messo in luce nel passato da autori come l’inglese Ricardo, e l’italiano dimenticato Achille Loria. Così il conflitto fondamentale della società diventa non quello dentro la fabbrica (imprenditore-lavoratore) ma quello tra redditieri e il mondo dell’impresa nel suo insieme (lavoro e imprenditori).
Infine, che il capitalismo abbia bisogno di uno ‘spirito’ lo aveva capito non solo Max Weber all’inizio del Novecento, ma molti altri autori, tra i quali il nostro Amintore Fanfani, uno storico economico oggi da rivalutare. Lo stesso Weber, e poi il filosofo Walter Benjamin, si erano spinti ancora più avanti, arrivando a sostenere che il capitalismo fosse una vera e propria religione: “nel capitalismo bisogna scorgervi una religione, perché nella sua essenza esso serve a soddisfare quelle medesime preoccupazioni, quei tormenti, quelle inquietudini, cui in passato davano risposta le cosiddette religioni. … In Occidente, il capitalismo si è sviluppato parassitariamente sul cristianesimo” (Il Capitalismo come religione, 1921). E con capacità profetica aggiungeva: “In futuro ne avremo una visione complessiva”.
Oggi infatti il capitalismo finanziario si trova difronte al rischio di diventare il ‘sistema di Polifemo”, che non inglobava gli ospiti, ma li divora. Il dominio della rendita sui flussi di lavoro e di reddito (e quindi la diminuzione degli investimenti nelle imprese), se esteso su scala globale può portarci in un mondo dove la disoccupazione di grandi masse di cittadini può diventare una condizione stabile per 1/3 della popolazione mondiale. E la domanda cruciale diventa come si comporterà questo terzo: come Ulisse?
Ovviamente, la visione di Magatti e Gherardi si muove in una prospettiva generativa di speranza, ma non per questo può evitarci di porci anche queste altre domande difficili.