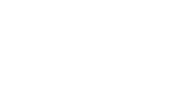di Luigino Bruni
pubblicato su generativita.it il 24/07/2011
![]() “L’economia politica è impopolare presso il grosso pubblico. La guerra, il dopoguerra e la crisi hanno dato tanti e tali smentite a previsioni in apparenza rigorosamente scientifiche, avanzate da economisti, e non c’è da stupirsi se qualche profano abbia potuto credersi autorizzato a proclamare la bancarotta dell’Economia politica.
“L’economia politica è impopolare presso il grosso pubblico. La guerra, il dopoguerra e la crisi hanno dato tanti e tali smentite a previsioni in apparenza rigorosamente scientifiche, avanzate da economisti, e non c’è da stupirsi se qualche profano abbia potuto credersi autorizzato a proclamare la bancarotta dell’Economia politica.
Ond’è che talora avviene che gli economisti devono prendere posizione contro la falsa notizia della morte della loro scienza. Alle voci, certo calunniose, non fa difetto un’attuante. Perché infatti molti economisti hanno peccato d’immodestia. Alla vigilia stessa della guerra mondiale, troppi hanno proclamato, a nome delle leggi economiche, che la guerra non poteva farsi, o che la se la si poteva fare, le forze vive delle nazioni si sarebbero entro stretto limiti di tempo esauriti. Ciononostante, la guerra fece il suo corso per molti anni, smentendo ed esaurendo i suoi negatori. Ai primordi della crisi economica, poi, altri economisti non si sono peritati di dichiarare in base ad una fallace scienza della congiuntura, che la crisi non poteva scoppiare o che scoppiano sarebbe stata presto domata”.[1]
C’è un aspetto bizzarro nei dibattiti che hanno fatto seguito alla crisi di questi ultimi anni, dalla quale siamo bel lungi dall’esserne usciti: si mettono in discussione regole, leggi, controlli del mercato finanziario, ma non si parla più seriamente di mettere in discussione seriamente la sola cosa veramente importante: il sistema economico capitalistico, e con esso la natura e la giustificazione etica del profitto. Dopo Pasolini o Don Milani, sembra che nei nostri intellettuali manchi la statura morale e il coraggio delle idee per immaginare un “oltre” a questo capitalismo, e alle tante parole logore delle ideologie, di destra e di sinistra, laiche o cattoliche. Ci si limita, così, tutti, a parlare più innocuamente del bisogno di una economia più etica (sperando che qualcuno ci spiegherà un giorno che cosa questa frase significhi veramente e seriamente: è l’etica del lupo o quella dell’agnello? L’etica dei titolari dei titoli di stato o quella degli immigrati?), di impresa socialmente responsabile, di non profit e di filantropia, tutti fenomeni che, a guardarli bene, non solo non mettono in discussione il nostro sistema economico, ma sono ad esso funzionali e necessari.
Sono invece convinto che occorra osare di più. C’è bisogno che gli intellettuali, gli economisti e gli scienziati sociali tornino a fare il loro mestiere di critici della società, anche della loro e della nostra. Il capitalismo è la forma che l’economia di mercato ha preso un paio di secoli fa in Europa e in Nord America, e come tutte le realtà storiche, è destinato ad evolvere in altro. E se lo guardiamo da vicino ci accorgiamo che di capitalismi ne abbiamo avuti già diversi, e quello tecnocratico e finanziario che stiamo conoscendo oggi è già ben diverso da quello di fine ottocento, dal capitalismo sociale europeo del secondo dopoguerra, ma anche da quello precedente alla globalizzazione dei mercati. In queste diversi fasi che il sistema economico che possiamo chiamare capitalismo ha attraversato c’è un elemento che è rimasto pressoché costante e preso come un dato di natura (se si eccettuano alcuni momenti del dopoguerra europeo e italiano), vale a dire che lo scopo dell’impresa sia e debba essere la missimizzazione del profitto, e che questo profitto, una pagate le tasse, confluisca nelle tasche capienti degli azionisti. Come se sia naturale e eticamente irrilevante che la gran parte del valore aggiunto che creano le imprese diventi proprietà dei soli azionisti dell’impresa. In realtà ci sono stati e ci sono movimenti di pensiero e di azioni che hanno sfidato il dogma del profitto. Il movimento cooperativo, parte della Dottrina Sociale della Chiesa, movimenti socialisti, la Teologia della liberazione, il movimento Gandhiano, e oggi parte dell’economia sociale, di comunione o solidale nel mondo (soprattutto in America Latina), ma tali movimenti o hanno perso la capacità di presentarsi come sistema economico alternativo, o sono talmente ridotti nelle loro dimensioni da non impensierire il sistema economico dominante, i cui protagonisti spesso semplicemente ignorano anche la sola esistenza di queste reali o sedicenti alternative. Il Novecento, almeno fino agli anni Settanta, ha vissuto una stagione di grande fermento sociale e ideologico, e non solo per la presenza di interi Paesi ad economia non capitalistica, ma anche per la presenza, nel seno delle economie capitaliste, di forme di economia non-capitalistica che hanno cercato di far evolvere l’economia di mercato su traiettorie diverse. Oggi, a distanza di qualche decennio, dobbiamo riconoscere che questi tentativi non-capitalistici all’interno del sistema capitalistico sono stati riassorbiti e stanno progressivamente perdendo i tratti di proposta alternativa. Basti pensare al modello cooperativo, che nei suoi fondatori doveva seriamente rappresentare un’alternativa sistemica all’impresa privata, e che oggi, tranne rare e luminose eccezioni (come parte delle imprese sociali in Italia, ad esempio), è divenuto troppo simile alle banche, supermercati e aziende agricole capitalistiche. Certo, senza le esperienze storiche del movimento cooperativo oggi l’economia “normale” sarebbe meno etica ed umana, poiché si è verificato in vari modi una contaminazione di valori e di umanità; ma la contaminazione che ha agito nella direzione opposta (ogni contaminazione tra organismi viventi è sempre reciproca) è stata più forte e penetrante, e oggi sono più i supermercati coop ad assomigliare ai supermercati delle multinazionali for-profit che non viceversa, e di gran lunga.
Eppure tra le righe sta emergendo con forza una stagione di disagio nei confronti della diseguaglianza nella distribuzione del reddito (l’economia capitalistica aumenta, non riduce, le diseguaglianze: oggi questo è dato empirico, non ideologico), nei confronti degli stipendi milionari di top manager, dei grandi privilegi che consentono gli alti profitti di pochi. Per poter però rispondere adeguatamente a queste nuove domande, c’è bisogno di lavoro teorico e culturale, di ritornare a porre questioni profonde e difficili sull’impresa, sul profitto, sul sistema capitalistico.
Occorre allora ripartire innanzitutto dalla domanda: ‘che cosa è il profitto?’. Se ci limitiamo soltanto all’ambito dell’economia reale (tralasciando la discussione sulla natura dei “profitti” delle speculazioni), possiamo affermare che il profitto è la parte di valore aggiunto generato dall’attività d’impresa che viene attribuita ai proprietari o agli azionisti, a quelli che una volta si chiamavano i capitalisti. Il profitto quindi non è l’intero valore aggiunto, ma solo una parte; e chi se ne appropria non è necessariamente l’imprenditore, ma il capitalista (occorre ricordare che anche in Marx il conflitto radicale non è tra imprenditore – figura ancora poco stagliata nell’Ottocento – e operai, ma tra capitalista e lavoratori). Facciamo un esempio. Un’impresa A produce automobili, trasformando acciaio, plastica, gomma, componenti elettronici, … in un prodotto finito che chiamiamo “auto”. Supponiamo che la somma dei costi di produzione di A per produrre un’auto sia pari a 10. Se l’impresa A vende un’auto al prezzo di 30, il profitto non è evidentemente pari a 20 (30-10). Tra i costi mancano ancora importanti elementi, tra i quali uno cruciale è il costo del lavoro. Se supponiamo che il costo del lavoro sia 8 (per ogni auto), e che gli altri costi (oneri finanziari, ammortamenti …) siano pari a 3, il profitto lordo (prima delle imposte) sarebbe pari a 9. Se l’impresa paga poi imposte per 4, ecco allora che il profitto netto diventa 5.
A questo punto nascono almeno due domande. La prima: da dove nasce, e da cosa dipende, questo profitto?
La storia del pensiero economico è anche una storia delle diverse teorie sulla natura del profitto. Schumpeter, ad esempio, cento anni fa sosteneva che il profitto fosse il “premio dell’innovazione” dell’imprenditore, è cioè la remunerazione della capacità innovativa dell’imprenditore. Marx, mezzo secolo prima di lui, aveva invece affermato che il profitto non è altro che un furto che i capitalisti fanno nei confronti dei lavoratori, poiché l’unica vera sorgente del valore aggiunto è il lavoro umano, in particolare di quello dei lavoratori i soli capaci di creare un plus valore dei beni – una linea di pensiero che va da Aristotele ai Padri della Chiesa, da Proudhon a Marx. Oggi sappiamo che nel valore aggiunto ci sono tante cose, tra le quali certamente la creatività dell’imprenditore (e dei managers), ma anche il lavoro di tutti gli altri attori dell’impresa (che certamente contribuisce al valore dei beni per un valore maggiore rispetto al solo costo di salari e stipendi), le istituzioni della società civile, la cultura tacita di un popolo (come di ricorda Giacomo Becattini a proposito dei distretti industriali), la qualità dei rapporti famigliari nei quali crescono i bambini nei primi anni di vita (come ci ha mostrato il Premio Nobel James Heckman): ciò che comunque è certo che in quel “5” di profitti non c’è solo il ruolo creativo dei proprietari dei mezzi di produzione dell’impresa, ma c’è molto di più, un ‘di più’ che ha a che fare con la vita dell’intera impresa e collettività.
C’è anche questa consapevolezza dietro all’articolo 41 della Costituzione italiana, quando dichiara la “funzione sociale” dell’impresa, una funzione che è anche una natura sociale dell’impresa e del profitto. Una cosa è comunque certa: se l’impresa A vende le auto a 30, e 5 sono i profitti, in un ipotetico mondo “non profit” (cioè con profitti 0) le auto costerebbero 25 invece di 30 (o ancora meno, se ipotizziamo che i profitti non sono soltanto 5 ma 15 o 20 o 2000, come le vicende del recente capitalismo finanziario ci mostrano).
In altre parole, i profitti delle imprese sono anche una forma di tassa sui beni acquistati dai cittadini che riducono il benessere collettivo della popolazione. Ecco perché una “economia non-profit” è stata spesso desiderata, sognata, e in certi momenti storici realizzata su piccola o vasta scala, sebbene creando spesso danni maggiori dei problemi che si volevano risolvere, come nel caso degli esperimenti collettivisti del XX secolo. Questi esperimenti collettivisti non hanno funzionato per tante ragioni, e tutte molto profonde, ma una di queste ragioni si è rilevata decisiva, l’esserci cioè resi conto che quando si toglie quel “5” e lo si socializza, chi deve dar vita ad imprese (lo Stato o i privati) non si impegnano più, o non abbastanza e per lungo tempo, nell’innovare e nel lavorare, e la ricchezza, non solo economica, della nazione diminuisce, ci si impoverisce e sparisce anche quel valore (5) che si vorrebbe socializzare. Eloquente è a questo riguardo un passaggio di uno dei fondatori dell’economia neoclassica, l’italiano Maffeo Pantaleoni, il quale in uno scritto dei primi del Novecento sfidava “gli ottimisti” a dimostrare che le motivazioni che portano “gli spazzini a spazzare le strade, la sarta a fare un abito, il tramviere a fare 12 ore di servizio sul tram, il minatore a scendere nella mina, l’agente di cambio ad eseguire ordini, il mugnaio a comperare e vendere il grano, il contadino a zappare la terra, etc. [fossero] l’onore, la dignità, lo spirito di sacrificio, l’attesa di compensi paradisiaci, il patriottismo, l’amore del prossimo, lo spirito di solidarietà, l’imitazione degli antenati e il bene dei posteri [e non] soltanto un genere di tornaconto che chiamasi economico”.[2] Al tempo stesso, questa grande crisi che stiamo vivendo ci sta dicendo che l’economia fondata sui profitti e sulla speculazione è altrettanto insostenibile. Che fare allora?
Quanto sta oggi accadendo nell’ambito della cosiddetta economia civile o sociale, nella grande tradizione cooperativa o nell’Economia di comunione, può essere letto in due modi, molto diversi tra di loro. Una prima lettura, minimalista e conservatrice, legge l’economia sociale come il “tappabuchi” del sistema capitalistico: l’impresa normale for-profit non riesce ad occuparsi dei “vinti” che restano lungo la strada (nel linguaggio di Giovanni Verga), e occorre qualcun altro che oggi svolga la funzione che la famiglia e le chiese hanno svolto nel passato. È la logica del 2%, che lascia intatto il restante 98% (economia for profit), poiché non mette in discussione i rapporti di produzione nella società. C’è invece un’altra lettura di questo movimento di economia civile: immaginare, per ora su piccola scala, un sistema economico dove il valore aggiunto, economico e sociale, venga distribuito tra tanti (e non solo agli azionisti), senza però che gli imprenditori e i lavoratori, “i tramvieri e gli spazzini” non si impegnino più per mancanza di incentivi, per evitare di cadere negli stessi problemi delle economia collettiviste e socialiste.
La scommessa più radicale e seria della economia di mercato che ci attende sarà allora mostrare una nuova stagione di imprenditori (singoli individui ma anche comunità di imprenditori) che sono motivati da ragioni più grandi del profitto. L’ultima fase del capitalismo (che potremmo chiamare finanziario-individualista) nasce da un pessimismo antropologico, che in realtà risale almeno ad Hobbes: gli esseri umani sono troppo opportunisti e auto-interessati per pensare che possano impegnarsi per motivazioni più alte del tornaconto (come il bene comune). Non possiamo però lasciare a questa sconfitta antropologica l’ultima parola sulla vita in comune: abbiamo un dovere etico di lasciare a chi verrà dopo di noi uno sguardo più positivo sul mondo e sull’uomo. Ma perché tutto ciò non resti scritto sulla carta ma diventi vita, occorre un nuovo umanesimo, una nuova stagione educativa dove ci si educhi tutti, giovani bambini e adulti, ad una economia della condivisione creativa, dove si producano più beni collettivi, sociali, ambientali e relazionali.
Gli illuministi italiani del Settecento avevano capito e posto in cima all’agenda di riforma dell’Italia che la felicità è pubblica, perché o è di tutti o non è di nessuno. Oggi ci stiamo accorgendo, e pagando a caro prezzo, quando quella profezia settecentesca fosse vera, quando le sfide ambientali, il terrorismo, l’energia, l’emigrazione ci dicono che ancor più nell’era della globalizzazione non si può essere felici da soli, contro gli altri. In questa sfida il modello italiano, compresa la sua anima cooperativa e mutualistica, può e deve ancora dire molto, ne va della qualità della vita dentro e fuori i mercati dei prossimi decenni.
[1] Robert Michels, Economia volgare, economia pura, economia politica, Discorso inaugurale dell’Anno Accademico 1933-1934, università di Perugia, Donnini, Perugia, 1934, p. 1.
[2] Maffeo Pantaleoni, Erotemi di Economia, Laterza, Bari, 1925, I, p. 217.